I miei primi vent'anni di sbattezzo
I miei primi vent'anni di sbattezzo
Le cose belle non dicono
QHo partecipato alla Corte dei Miracoli di Siena all’Andrej. L’assenza di sé di Francesco Chiantese. Dico partecipato perché di questo si è trattato, e non di un assistere. Una stanza, al centro due sedie rosse e una tela, intorno, in uno stretto cerchio, il pubblico. Andrej è Andrej Rublëv, il pittore di icone russo, ma anche Andrei Tarkovsky, che all’artista ha dedicato uno dei suoi film migliori. Chiantese è in scena da solo, due voci fuori campo e un raggio di luce che di tanto in tanto trafigge il buio. Le voci lo interrogano, lo ammoniscono, lo inquietano. Finché giunge la sua, di voce. Che dice, tra l’altro: “Le cose belle non dicono. Le cose belle sono”.
Era da un po’ che non riuscivo a portare in questa città dove molto del mio mestiere è cominciato, proprio qui in questi spazi, uno dei miei più recenti inciampi.Chiamo così i miei spettacoli di ricerca: inciampi. Più o meno fortunati, più o meno piacevoli, inciampi. Uno questo termine perché, nel teatro di ricerca, non si va in scena per mostrare quello che si sa fare (quello, per me, è necessario in altre circostanze) ma quello che non si è ancora in grado di fare; non si mostra in scena una consapevolezza, ma un’intuizione, sghemba, fallace, fragile.
Il teatro è artigianato delle relazioni; si compie soltanto se la mia biografia e la tua biografia si compenetrano, in qualche modo, e ne nasce qualcosa che non appartiene a me quanto non appartiene a te: lo spettacolo. Tutto, tutto, tutto dev’essere in funzione di questo.
Le cose belle non dicono
QHo partecipato alla Corte dei Miracoli di Siena all'Andrej. L'assenza di sé di Francesco Chiantese. Dico partecipato perché di questo si è trattato, e non di un assistere. Una stanza, al centro due sedie rosse e una tela, intorno, in uno stretto cerchio, il pubblico. Andrej è Andrej Rublëv, il pittore di icone russo, ma anche Andrei Tarkovsky, che all'artista ha dedicato uno dei suoi film migliori. Chiantese è in scena da solo, due voci fuori campo e un raggio di luce che di tanto in tanto trafigge il buio. Le voci lo interrogano, lo ammoniscono, lo inquietano. Finché giunge la sua, di voce. Che dice, tra l'altro: "Le cose belle non dicono. Le cose belle sono".
Le liturgie di Marina Abramovic
Qualche nota sparsa sulla mostra di Marina Abramovic “The Cleaner” (Firenze, Palazzo Strozzi, fino al 20 gennaio 2019).
Come l’arte iconica, così l’arte liturgica di Abramovic attraversa le fasi del barocco, del realismo, dell’espressionismo, dell’arte di denuncia. Definirei barocche performances come “Imponderabilia” o “Luminosity”, nelle quali Abramovic cerca soprattutto il non comune, quell’insolito che, in una società nella quale la nudità dà ancora brividi, ha inevitabilmente la sfumatura dello scandaloso; espressionistica – psicanaliticamente espressionista – “The Freeing Series”; realismo (postmoderno) è quello di “The House with the Ocean View”, in cui l’artista vive per dodici giorni in una struttura sospesa, sotto gli occhi dei visitatori; arte di denuncia è quella di “Cleaning the Mirror” e di “Balkan Baroque”: due performances che hanno a che fare con la guerra, e con le ossa. Usciti dalla mostra, sono queste le immagini che restano dentro. L’immagine di un essere umano che cerca di lavare via lo sporco da uno scheletro, che è al tempo stesso protesta contro la guerra ed evocazione di un tempo in cui la morte e la vita non erano separati da una barriera invalicabile.
Abramovic ha studiato meditazione vipassana. Lo si nota in “Counting the Rice”, che mette i visitatori a dividere e contare chicchi di riso e lenticchie, vale a dire a compiere gesti minuti, attenti, apparentemente improduttivi. Liturgici.
Uscendo capita di pensare che sì, Abramovic ha compreso qualcosa di importante: che, morto Dio, morta la religione, abbiamo ancora bisogno di una liturgia, di gesti essenziali, esatti, che ci mettano in contatto con la vita e con la morte. E che la ricerca di questi gesti appartiene all’arte. A patto che non diventi anch’essa religione – sia pure la religione del mercato.
Nella foto: “Cleaning the Mirror”. Foto mia.
Lettera aperta a un leghista foggiano
Gentile Joseph Splendido,
fino a qualche giorno fa ignoravo la sua esistenza; ieri l’altro mi sono imbattuto per caso nel suo profilo Facebook. C’era un video dell’incendio che qualche giorno fa ha colpito il ghetto di Borgo Mezzanone, uno dei luoghi in cui una concezione feudale dei rapporti di lavoro – Fabrizio Gatti parlava semplicemente di schiavitù – costringe a vivere i lavoratori africani delle campagne della Capitanata. Baracche di lamiera e legno che spesso vanno a fuoco, come è successo lo scorso anno al Gran Ghetto di Rignano, dove sono morti tra le fiamme due braccianti del Mali, mentre ad agosto dodici braccianti hanno perso la vita mentre tornavano dal lavoro in uno dei tanti furgoni privi dei requisiti minimi di sicurezza con i quali il caporalato gestisce gli spostamenti dei lavoratori-schiavi. L’incendio dell’altro giorno ha fatto diversi feriti, alcuni gravi. Sul suo profilo lei ha commentato così: “La nostra Puglia continua a subire l’onta dell’illegalità e dell’immigrazione clandestina”. Ha ragione. E’ motivo di vergogna che esistano clandestini, e che siano costretti a vivere in baracche che vanno a fuoco. Ho qualche dubbio però sul fatto che si tratti di qualcosa che la Puglia subisce. Ma vorrei parlarle di un’altra cosa.
Le liturgie di Marina Abramovic
Qualche nota sparsa sulla mostra di Marina Abramovic "The Cleaner" (Firenze, Palazzo Strozzi, fino al 20 gennaio 2019).
Lettera aperta a un leghista foggiano
fino a qualche giorno fa ignoravo la sua esistenza; ieri l'altro mi sono imbattuto per caso nel suo profilo Facebook. C'era un video dell'incendio che qualche giorno fa ha colpito il ghetto di Borgo Mezzanone, uno dei luoghi in cui una concezione feudale dei rapporti di lavoro - Fabrizio Gatti parlava semplicemente di schiavitù - costringe a vivere i lavoratori africani delle campagne della Capitanata. Baracche di lamiera e legno che spesso vanno a fuoco, come è successo lo scorso anno al Gran Ghetto di Rignano, dove sono morti tra le fiamme due braccianti del Mali, mentre ad agosto dodici braccianti hanno perso la vita mentre tornavano dal lavoro in uno dei tanti furgoni privi dei requisiti minimi di sicurezza con i quali il caporalato gestisce gli spostamenti dei lavoratori-schiavi. L'incendio dell'altro giorno ha fatto diversi feriti, alcuni gravi. Sul suo profilo lei ha commentato così: "La nostra Puglia continua a subire l'onta dell'illegalità e dell'immigrazione clandestina". Ha ragione. E' motivo di vergogna che esistano clandestini, e che siano costretti a vivere in baracche che vanno a fuoco. Ho qualche dubbio però sul fatto che si tratti di qualcosa che la Puglia subisce. Ma vorrei parlarle di un'altra cosa.
L'ENI, l'Africa e noi
African Metropolis è la grande mostra che il MAXXI di Roma dedica alla nuova arte africana. Un evento in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la partnership dell’Eni, che all’interno della mostra ha creato un suo spazio espositivo, DATAFRICA, con installazioni che presentano semplici dati sul continente, senza alcuna immagine. Un percorso interattivo tra cifre, mappe, diagrammi, che è accompagnato da una narrazione tranquillizzante. Nella pagina del sito dell’Eni dedicata all’evento è messa in bella mostra una citazione tratta dal Corriere della Sera: “Da parecchi anni noi investiamo in 14 Paesi africani, dall’Angola alla Nigeria passando per Congo e Mozambico, con l’obiettivo di affiancare all’attività estrattiva programmi di sostegno delle economie e delle comunità locali: centrali elettriche, impianti eolici, solare fotovoltaico per dare energia alle famiglie e alle imprese di vari Paesi. Ma anche investimenti in agricoltura e in riforestazione.” A parlare è l’amministratore delegato Claudio Descalzi. Una narrazione che l’ENI ha, naturalmente, i mezzi economici per diffondere sulla stampa, compreso l’acquisto di un vistoso spazio pubblicitario sulla presente testata. Ma è una narrazione vera?
Consideriamo alcuni dati che con ogni probabilità mancano nel percorso del MAXXI.
161 su 180. E’ il posto che, secondo Trasparency International, il Congo francese occupa a livello mondiale nella classifica dei paesi con maggiore corruzione percepita.
15 milioni di euro. E’ la cifra irrisoria che, secondo un’inchiesta dell’Espresso, l’Eni avrebbe speso per acquistare, nel corrottissimo Congo francese, il Marine XI, un enorme giacimento petrolifero sottomarino. L’operazione sarebbe avvenuta attraverso un complesso sistema di società offshore.
1,3 miliardi di dollari. A tanto ammonterebbe, secondo la procura di Milano, la tangente pagata da Claudio Descalzi per l’acquisizione di una concessione petrolifera in Nigeria.
40 anni. E’ l’aspettativa di vita del Delta del Niger, dove si trovano la maggior parte dei pozzi petroliferi dell’Eni, mentre nel resto della Nigeria è di 53-55 anni.
2 milioni di euro. E’ il risarcimento che cinquemila abitanti di una tribù del Delta del Niger chiedono come risarcimento per un disastro ambientale avvenuto nel 2010.
11.000. E’ il numero di bambini che secondo uno studio dell’Università di St. Gallen, in Svizzera, sono morti entro il primo anno di età a causa delle perdite di petrolio nel Delta del Niger. Secondo l’Eni e le altre compagnie petrolifere, lo sversamento di petrolio è dovuto alle azioni di vandalismo delle popolazioni, che cercano di spillare il petrolio dalle condutture per rivenderlo, ma non è da escludere che molte perdite siano dovute allo fatiscenza delle condutture. “Qualunque sia la causa – osserva Amnesty International -, secondo la legge nigeriana le compagnie petrolifere sono responsabile di contenere e ripulire le perdite e riportare le aree contaminate al loro stato originario. Tuttavia, ciò accade di rado. Di conseguenza, la gente nel Delta del Niger vive con l’impatto cumulativo di decenni di inquinamento”.
Corruzione, inquinamento, morte. Non compaiono nel giallo rassicurante dell’advertising di Eni, né nella retorica neo-coloniale che accompagna l’iniziativa, nella quale si parla perfino di “un futuro inclusivo”.
“Sono le bugie che sono state martellate / nelle tue orecchie per una generazione / […] E’ questo / caro amico, che trasforma il nostro mondo / in una tetra prigione”, scriveva il poeta nigeriano Ken Saro-Wiwa. Lo scriveva nel 1991, quattro anni prima di essere condannato a morte per aver reclamato i diritti della gente del Delta del Niger contro le multinazionali del petrolio.
Articolo pubblicato su Gli Stati Generali, 23 ottobre 2018.
Palio: il dialogo necessario
Nella foto: i cavalli prima del palio del 20 ottobre. Foto di Antonio Vigilante.
Articolo pubblicato su Gli Stati Generali, 23 ottobre 2018.
L'ENI, l'Africa e noi
Palio: il dialogo necessario
Assaporare il disgusto
La capotreno e il rispetto delle regole
La capotreno e il rispetto delle regole
Georges Lapassade, ancora
Quando ho cominciato a insegnare, ormai vent’anni fa, non avevo molti libri nel mio bagaglio leggero di giovane docente. L’università mi aveva formato soprattutto sulla fenomenologia, l’ermeneutica e il personalismo, ma nessuna di queste teorie mi persuadeva. Presa la laurea, ho cominciato da zero o quasi il lavoro di farmi una cultura filosofica e pedagogica adeguata al mio sentire; un lavoro che non è ancora finito.
Tra i pochi libri che portavo idealmente con me, il giorno in cui per la prima volta ho messo piede in un’aula scolastica, c’era L’analisi istituzionale di Georges Lapassade. Avevo incontrato le idee e la prassi di Lapassade durante uno dei lavori tentati alla ricerca di una mia via: pedagogista in una cooperativa educativa. Una cooperativa che era seguita da Lapassade e ne adoperava il metodo dell’autogestione: ragazzini anche molto piccoli (di quelli che si definiscono difficili) erano chiamati alla gestione condivisa della comunità educativa. La prima volta che misi piede come docente in un’aula scolastica lo feci con quel modello educativo, e ben presto sperimentai quanto l’istituzione scolastica sia chiusa non tanto alla sperimentazione in sé, quanto a sperimentazioni che ne mettano in discussione realmente, e non solo retoricamente, i rapporti di potere.
Lapassade è stato uno dei protagonisti più vivaci, anche se non tra i più noti, del Sessantotto. E chi ha provato a portarne a scuola la pratica sa quanto sia superficiale, sciocca, storicamente arbitraria la diffusa analisi che attribuisce i mali attuali della scuola italiana a una presunta influenza nefasta del Sessantotto. A distanza di cinquant’anni c’è da interrogarsi piuttosto su quanta istanze pedagogiche del Sessantotto rappresentino ancora una sfida per la scuola; quanto, cioè, autori come Lapassade siano ancora attuali. Per questo risulta prezioso un libro come Educazione e pedagogia autogestionaria. Una ricerca su Georges Lapassade di Carla Gueli (Sensibili alle foglie, Roma 2018). Un libro che nasce appunto dalla necessità e dall’urgenza di affrontare il nonsenso quotidiano della scuola, interrogando dal di dentro l’istituzione attraverso la voce delle persone che la costituiscono quotidianamente. Si parla molto, a scuola, di educazione al pensiero critico, ma pare che l’istituzione stessa sia escluda da questa analisi critica: non accade mai, o quasi, che studenti e docenti si fermino ad analizzare il senso, l’origine, la direzione, la natura e la struttura, i fini evidenti e quelli latenti dell’istituzione scolastica. Non è difficile comprenderne le ragioni. Chi analizza criticamente la scuola giunge ben presto alla questione del potere. E se si critica il potere scolastico, l’istituzione crolla. O si trasforma profondamente. In uno dei suoi libri più potenti, L’entrée dans la vie (1963), tradotto in italiano con il titolo Il mito dell’adulto, Lapassade mette in discussione uno dei capisaldi della concezione pedagogico-scolastica. Gli adulti hanno il diritto/dovere di educare i giovani, e di farlo con un giusto ricorso all’autorità ed alla disciplina, perché rappresentano l’umano giunto a compiutezza. Ma ciò che caratterizza la specie umana, osserva Lapassade, è una costante incompiutezza, l’essere sempre in formazione, senza che si possa individuare un momento in cui il processo è compiuto e l’educazione ha raggiunto la sua fine. Si tratta di tesi che all’epoca risultavano fortemente provocatorie e lo sono per molti versi anche oggi, ma in fondo, ricorda Gueli, anticipano quella esigenza di una educazione permanente che oggi è universalmente riconosciuta. Senza che se ne traggano, però, tutte le conclusioni pedagogiche, perché se anche l’adulto è in formazione, allora scompare la distinzione netta tra insegnante e alunno, e bisogna parlare piuttosto di una comunità di soggetti in formazione. Che è ciò che Lapassade cercava con la pratica dell’autogestione, che rappresenta anche un modo per riscoprire la relazione umana oltre il sistema burocratico. “Il solo modo di proteggersi dalla relazione umana è di sopprimerla, non bisogna che l’altro continui ad essere l’origine di una relazione, bisogna che egli non ne costituisca più che il termine”, scriveva ne L’analisi istituzionale (Istituto Editoriale Internazionale, Milano 1974, p. 126). Lo avvertono ogni giorno gli studenti: ciò che chiedono più di ogni altra cosa è una relazione umana reale. Quello che ottengono, quotidianamente, è un sistema relazionale freddo, con ruoli rigidi, nel quale l’ossessione per le regole, la disciplina, il controllo si esprime in forme che altrove sarebbero bizzarre: un problema relazionale è risolto non con un confronto umano, magari anche acceso, ma con il ricorso al testo scritto del rapporto disciplinare. Un sistema che ha conseguenze anche sull’apprendimento, poiché l’apprendimento reale è sempre un fatto sociale, nasce dal confronto, dalla discussione e ricerca comune, non dalla serialità dello studio individuale, in competizione con l’altro, centrato sul protocollo lezione-manuale-interrogazione.
Pensatore rivoluzionario, Lapassade non si accontenta di mezze soluzioni. Seguendo Sartre, interpreta il passaggio dal gruppo alla istituzione come caratterizzato dal giuramento, che rende stabile il gruppo e gli garantisce il futuro, ma solo a costo di una fase di terrore, che è dunque all’inizio dell’istituzione. Non è sufficiente qualche intervento per democratizzare l’istituzione: occorre che i gruppi la analizzino criticamente e ne ribaltino la struttura, smettendo di esserne gestiti e passando alla autogestione. Una azione che, afferma, “sarà sempre, almeno in parte, allo stato di progetto, perché la rivoluzione non sarà mai definitivamente compiuta” (p. 67, citazione da Processo all’Università, del 1969). In questa proposta le istanze libertarie esistenti da tempo nella pedagogia europea e nordamericana, da Freinet a Rogers, da Neill a Illich, sono espresse con la piena consapevolezza del significato politico di una rivoluzione pedagogico-istituzionale, ed è qui la loro forza, ma anche la loro debolezza, nel momento in cui la società smarrisce lo slancio rivoluzionario.
Rileggere oggi Lapassade può sembrare impresa disperata, se si considera la spoliticizzazione attuale degli studenti, la loro scarsa propensione a discutere ruoli, poteri, dinamiche sociali, il ripiegamento sul privato; se si considera, ancora, il disorientamento degli stessi docenti, sempre più in difficoltà, anzi in imbarazzo in una istituzione che, non più attraversata da fremiti rivoluzionari, appare poco credibile anche come strumento della conservazione sociale. E’ invece un atto di speranza. E di ribellione. Attingendo a Lapassade a più in generale alla pedagogia istituzionale, scrive Gueli concludendo il suo libro, “si potrebbe forse trovare un terreno fertile per coltivare una nuova possibilità creativa e immaginifica, per elaborare modelli educativi resistenti a quelli del mercato, per immaginare i luoghi educativi come comunità dinamiche di ricerca e sperimentazione. Potrebbero forse così generarsi esplorazioni collettive generatrici di forme di educazione volte a costruire una rinnovata, benchè incompiuta, umanità” (p. 101). Resistenza è, qui, la parola chiave. Non è il tempo della rivoluzione, è il tempo della resistenza. E in campo educativo vuol dire non dimenticare che un’alternativa è possibile. Realizzabile? Si vedrà. Ma intanto importa sapere che è necessaria.
Articolo pubblicato su Gli Stati Generali, 28 settembre 2018.
Georges Lapassade, ancora
Tra i pochi libri che portavo idealmente con me, il giorno in cui per la prima volta ho messo piede in un'aula scolastica, c'era L'analisi istituzionale di Georges Lapassade. Avevo incontrato le idee e la prassi di Lapassade durante uno dei lavori tentati alla ricerca di una mia via: pedagogista in una cooperativa educativa. Una cooperativa che era seguita da Lapassade e ne adoperava il metodo dell'autogestione: ragazzini anche molto piccoli (di quelli che si definiscono difficili) erano chiamati alla gestione condivisa della comunità educativa. La prima volta che misi piede come docente in un'aula scolastica lo feci con quel modello educativo, e ben presto sperimentai quanto l'istituzione scolastica sia chiusa non tanto alla sperimentazione in sé, quanto a sperimentazioni che ne mettano in discussione realmente, e non solo retoricamente, i rapporti di potere.
Quant'è falso (e pericoloso) Dio
Superati i settant’anni Sergio Givone, che conosciamo come uno dei massimi filosofi italiani, s’accorge d’aver sbagliato mestiere e ci consegna un’enciclica: Quant’è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione (Solferino, Milano 2018). Il titolo è azzeccato, e davvero rincresce che non sia venuto in mente a qualcuno degli ultimi papi, ai quali non si può rimproverare, tuttavia, di non aver pensato quello che si trova oltre il frontespizio. La tesi è semplice semplice, ed è tutta nel sottotitolo: non possiamo fare a meno della religione, perché se neghiamo Dio finiamo per negare anche l’uomo. Sì, Dostoevskij: se Dio non esiste, tutto è permesso. Poiché centottanta pagine bisogna pur riempirle, Givone aggiunge Berdiaev, Pareyson. Agamben e perfino un po’ di Habermas. Fosse stato più audace, avrebbe aggiunto anche un Ferdinando Tartaglia, e il discorso forse sarebbe diventato più interessante. Così com’è, non è che una stanca, piatta, inutile variazione su uno dei temi più stantii della pubblicistica cattolica degli ultimi decenni.
Primo compito d’un filosofo dovrebbe essere il rigore: rigore nell’argomentazione, rigore nella definizione dei termini. Che cosa vuol dire che non possiamo fare a meno della religione? Noi chi? Noi esseri umani, noi europei? E cos’è la religione? E cos’è Dio? Quale Dio? Non uno di questi concetti è scontato. Esistono religioni senza Dio, come il buddhismo. Givone sostiene che dopo duemila e cinquecento anni i buddhisti non possono, ora, fare a meno di Dio? Ma lo stesso buddhismo è poi una religione? Il concetto indiano di dharma solo molto approssimativamente può essere ricondotto a quello occidentale di religione. Di cosa abbiamo allora bisogno?
Quant'è falso (e pericoloso) Dio
Superati i settant'anni Sergio Givone, che conosciamo come uno dei massimi filosofi italiani, s'accorge d'aver sbagliato mestiere e ci consegna un'enciclica: Quant'è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione (Solferino, Milano 2018). Il titolo è azzeccato, e davvero rincresce che non sia venuto in mente a qualcuno degli ultimi papi, ai quali non si può rimproverare, tuttavia, di non aver pensato quello che si trova oltre il frontespizio. La tesi è semplice semplice, ed è tutta nel sottotitolo: non possiamo fare a meno della religione, perché se neghiamo Dio finiamo per negare anche l'uomo. Sì, Dostoevskij: se Dio non esiste, tutto è permesso. Poiché centottanta pagine bisogna pur riempirle, Givone aggiunge Berdiaev, Pareyson. Agamben e perfino un po' di Habermas. Fosse stato più audace, avrebbe aggiunto anche un Ferdinando Tartaglia, e il discorso forse sarebbe diventato più interessante. Così com'è, non è che una stanca, piatta, inutile variazione su uno dei temi più stantii della pubblicistica cattolica degli ultimi decenni.
Primo compito d'un filosofo dovrebbe essere il rigore: rigore nell'argomentazione, rigore nella definizione dei termini. Che cosa vuol dire che non possiamo fare a meno della religione? Noi chi? Noi esseri umani, noi europei? E cos'è la religione? E cos'è Dio? Quale Dio? Non uno di questi concetti è scontato. Esistono religioni senza Dio, come il buddhismo. Givone sostiene che dopo duemila e cinquecento anni i buddhisti non possono, ora, fare a meno di Dio? Ma lo stesso buddhismo è poi una religione? Il concetto indiano di dharma solo molto approssimativamente può essere ricondotto a quello occidentale di religione. Di cosa abbiamo allora bisogno?
Poesia della natura offesa
La caccia è un pericolo per tutti
Non sapevo che fosse cominciata la stagione della caccia. Me lo hanno annunciato, questa mattina alle sette, le fucilate intorno a casa. Abito in una delle ultime case di un borgo sui colli senesi, in una via che si inoltra nella campagna, che la gente del luogo chiama “strada dei caprioli”: non è infrequente che un capriolo ti attraversi la strada. Quando vi portavo la mia cagna bisognava fare attenzione, perché l’istinto la portava ad inseguirli ed a perdersi con loro nei campi. La mia cagna, che non c’è più da quasi un anno, era una meticcia che aveva molto del segugio. Era stata abbandonata da un cacciatore perché poco abile. Il giorno prima che morisse le abbiamo fatto dei raggi: aveva – chissà da quanto – dei pallini nella gola, residuo di una fucilata.
Nel pomeriggio c’è stato un acquazzone, ora è tornato il sole. E sono tornate le fucilate.
Mentre loro sparano, io rifletto un po’. Lascio da parte ogni considerazione sugli animali. Credo che gli animali abbiano diritto alla vita, e che ucciderli per divertimento sia un atroce insulto alla vita, ma non è di questo che voglio parlare ora. Mi interrogo sul rischio che la caccia rappresenta per le persone e sulle contraddizioni singolari di questo paese. Non è difficile trovare dati sulla pericolosità della caccia. L’ultima stagione venatoria ha fatto 84 feriti e 30 morti. Dei morti, dieci erano persone estranee alla caccia. Dieci persone che hanno perso la vita perché altre persone volevano divertirsi andando in giro a sparare. Tra i morti c’è anche un minore. Ed è il dato sui minori il più agghiacciante: tra il 2007 e il 20015 sono stati uccisi dai cacciatori undici minori. Undici. Undici vite di bambini e adolescenti stroncate.
Dicevo delle contraddizioni. Viviamo in un paese ossessionato dalla sicurezza. Un paese in cui, nonostante tutti i dati dicano che da molto tempo ormai i reati più gravi, a partire dagli omicidi, sono in calo verticale, la gente ha una paura terribile. Una paura che esige poliziotti di quartiere, videocamere, uno spazio pubblico sempre più blindato, fogli di via sempre più facili per chiunque sia percepito come un pericolo, con il rischio sempre maggiore di violazioni. Una paura su cui si costruisce il successo politico. Ma come si spiega che gli stessi politici che alimentano l’ossessione per la sicurezza siano favorevoli alla caccia? Poco più di un mese fa Salvini ha difeso a spada tratta i cacciatori: “Giù le mani dalle nostre tradizioni, dalla nostra storia dalla nostra cultura. Se non ci fossero nei nostri boschi coloro che i nostri animali li amano e li curano sarebbero problemi per tutti”. E’ un esempio particolarmente efficace di quella offesa aperta, sfacciata alla verità che è propria del linguaggio dei regimi totalitari: chi insegue, stana ed uccide degli animali diventa uno che gli animali li ama e li cura. Ma, ripeto, qui non voglio parlare di animali. Mi interessano le vittime umane. Mi interessano le decine di bambini e ragazzi uccisi dai cacciatori. Mi interessa sapere che, quando avrò un figlio, tra quelle vittime potrebbe esserci anche lui. Tradizioni, storia, cultura? La caccia? Qualcuno dovrebbe informare Salvini che l’umanità è uscita dalla fase di caccia e raccolta da qualche millennio, e che legare la cultura italiana alla caccia è una delle offese più grandi che si possa fare a un paese che ha espresso ben altro, sul piano culturale. Ma soprattutto dovrebbe chiedergli quale risposta dà, “da ministro e da padre”, a chi per quella tradizione e cultura (più probabilmente: per qui volgarissimi interessi) ha perso un figlio.
Gli Stati Generali, 1 settembre 2018.
Cosa dovrebbe dire un ministro dell'istruzione (e cosa non dirà)
Poesia della natura offesa
La caccia è un pericolo per tutti
Nel pomeriggio c'è stato un acquazzone, ora è tornato il sole. E sono tornate le fucilate.
Mentre loro sparano, io rifletto un po'. Lascio da parte ogni considerazione sugli animali. Credo che gli animali abbiano diritto alla vita, e che ucciderli per divertimento sia un atroce insulto alla vita, ma non è di questo che voglio parlare ora. Mi interrogo sul rischio che la caccia rappresenta per le persone e sulle contraddizioni singolari di questo paese. Non è difficile trovare dati sulla pericolosità della caccia. L'ultima stagione venatoria ha fatto 84 feriti e 30 morti. Dei morti, dieci erano persone estranee alla caccia. Dieci persone che hanno perso la vita perché altre persone volevano divertirsi andando in giro a sparare. Tra i morti c'è anche un minore. Ed è il dato sui minori il più agghiacciante: tra il 2007 e il 20015 sono stati uccisi dai cacciatori undici minori. Undici. Undici vite di bambini e adolescenti stroncate.
Cosa dovrebbe dire un ministro dell'istruzione (e cosa non dirà)
Ripartiamo dall'ultimo romanzo di Francesca Melandri
Gli Stati Generali, 26 agosto 2018-











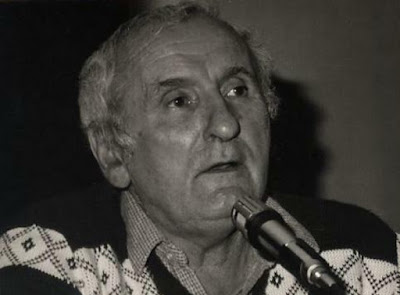







Nessun commento :
Posta un commento