Gli oscuri intenti di Bernardo Zannoni
Una faina. La vita di una faina. Un romanzo sulla vita di una faina. E non un romanzo qualsiasi: un romanzo che ha vinto il Campiello.
Come si racconta la vita di una faina? Bisognerà provare ad essere una faina. Chiedersi cos’è essere un animale. Qualcosa alla Uexküll, ma con in più il talento del narratore. Bello!
Questo pensavo, più o meno, apprestandomi alla lettura di I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni (Sellerio, Palermo 2021), con le migliori aspettative: sia perché, appunto, ha vinto il Campiello, sia perché se ne dice un gran bene.
Mi trovo subito alle prese con una faina che si chiama Archy. Perché Archy? Sarà perché le faine vivono negli Stati Uniti? Ma no. Il loro habitat è europeo e mediorientale. La nostra faina avrebbe più realisticamente potuto chiamarsi Peppino. Ma soprattutto: che faina è una faina che ha un nome? Per giunta parla. E dorme in un letto. Gli animali di Zannoni hanno il comodino e la lampada, e quando occorre chiamano il medico: e dunque no, niente Uexkül. Nessuno sforzo di essere una faina. Ma nemmeno ci si muove in un mondo disneyano: la cosa diventa chiara oltre ogni possibilità di equivoco quando la mamma di Archy fa saltare un occhio alla sorella con una zampata.
L'arte dei piaceri
Esistono due forme di piacere: il piacere dei cercatori di piacere e il piacere dei negatori del piacere. Il piacere dei primi è quello dell’acqua e del vino, del cibo e della musica, della lettura e del pensiero. I negatori del piacere hanno qualcosa di più alto, in genere qualche forma di dovere, e in nome di questo più alto negano, sdegnati, i piaceri. Il piacere in questo caso non è estetico, legato alla sensazione, ma nasce dalla percezione di sé in rapporto all’altro. Il negatore del piacere qui ed ora trae il suo piacere dal sentire di avere un posto nella società, o nel cosmo, perfino; di essere un soggetto riconosciuto. Per ottenere questo piacere più alto, o preteso tale, il nostro soggetto deve farsi seduttore: dell’altro o di Dio stesso. Può godere di sé solo nella misura in cui l’altro cede alla sua seduzione. E quando ciò riesce, potrà riposare nel suo io come in un nido. E godere di questo.
ChatGPT e la pulizia del water
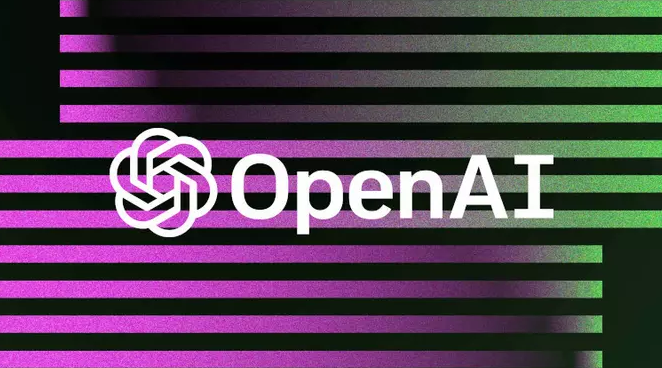
Il meritevole ministro dell’Istruzione e del merito, chiamato ad esprimersi su chatGPT, evita la condanna secca e riconosce che “Può essere impiegata per aiutare gli insegnanti a personalizzare l’apprendimento, ad adattare i contenuti in base alle attitudini individuali degli studenti, a monitorare i loro progressi e a fornire informazioni su come migliorare il loro rendimento”, pur aggiungendo che “L’intelligenza artificiale non può dunque soppiantare l’insegnante né marginalizzarne il ruolo, che è decisivo in tutti i gradi di scuola, in particolare nella primaria”. È singolare il modo in cui i giornali hanno riportato la notizia: alcuni hanno enfatizzato la prima parte, altri la seconda; per alcuni Valditara dice sì all’intelligenza artificiale, per altri afferma soprattutto che il docente è insostituibile.
Un altro mondo (virtuale) è possibile
Se dovessi sintetizzare in poche parole il mio ideale politico-sociale, direi più o meno questo: un sistema in cui gli Stati siano sostituiti da ma un insieme di città libere di federarsi con altre città, di stringere accordi commerciali e di creare insieme infrastrutture tecnologiche; ogni città sarà governata secondo il criterio della massima partecipazione possibile al potere.Sono ben consapevole che una simile realtà non ha molte speranze di realizzarsi, almeno a breve, anche se nel Rojava i curdi stanno facendo un tentativo coraggioso di praticare il municipalismo libertario di Murray Bookchin, filtrato dalla lettura di Abdullah Öcalan. Siamo però nel terzo decennio del secondo millennio, e la realtà che viviamo non è più solo la cara vecchia dimensione fisica. Abitiamo due mondi paralleli: il mondo fisico, reale (ma cosa è reale?) e quello virtuale. E a quanto pare – se le speranze di Zuckerberg non saranno deluse – nel futuro prossimo questo secondo mondo sarà sempre più presente nelle nostre vite. È anche, se non soprattutto, ormai, alla luce del mondo virtuale che dobbiamo saggiare la plausibilità dei nostri ideali.
Mi son dannato l'anima a cercare
Kaasher natati et-lebi lada’at hokmah welirot etha’inian asher na’asah ‘al-ha-aretz ki gam baiom ubalailah shenah be’enav roeh. Weroiti et-kol-ma’asah haelohim ki lo iukol haadam limzo et-hamahaseh asher lasah tahat-hashemesh beshel asher ‘ahamol haadam lebaqesh welo imza wegam im iomer hehokam lada’at lo iukol limzo.
Mi son dannato l’anima a cercare
conoscenza, saggezza, il senso ultimo
di tutto questo affare sulla terra
che ci toglie il riposo notte e giorno.
Ed ho visto che le opere di Dio
tutto quello che accade sotto il sole
l’uomo non può comprenderlo: e chi dice
d’esser sapiente ed afferrare il mondo
più degli altri è smarrito ed impotente.
Qohelet, 8, 16-17. Traduzione di Antonio Vigilante.
Trema lacrime il bimbo solitario
Trema lacrime il bimbo solitario
se il ventre abituale cede al buio
e gli germina il fiato d’altri mondi:
una vecchia che striscia minacciosa
sulla lucida schiena d’un serpente
seguita da un corteo di spiritelli
corrosi da vermetti incandescenti.
Trema lacrime l’uomo solitario
preso alla gola da tristezza e angoscia
e vede e teme minacce di tenebra
non più vere di quelle d’un bambino.
L’anima nostra soffre di terrore:
non bastano a guarirla il giorno e il sole.
Si studi la natura, si contempli
la verità delle sue leggi eterne.
Lucrezio, De Rerum Natura, III, 87-93. Traduzione di Antonio Vigilante.
La paura e il potere
La prima volta che ho tradotto questi versi avevo diciassette anni. Era un esercizio: tradurre più cose possibile in endecasillabi, perché volevo che l’endecasillabo mi venisse naturale come il respiro. E tradussi Lucrezio (il secondo e il terzo libro per intero), e Orazio, e Baudelaire. Ed altro ancora. Credo di aver imparato da questi versi di Lucrezio più che da qualsiasi testo di filosofia. Ho imparato che dietro la maschera del potere c’è la miseria umana; che il potente, quasi non-uomo per la sua arroganza, per il ghigno che disgusta ed indigna, è in realtà un poveraccio, corroso dentro dal cancro del terrore. Non si possono leggere forse questi versi straordinari come un ritratto della classe politica della disgraziata Italia di oggi? Non li conosciamo, quei gusci vuoti che “ridono ai funerali dei fratelli” (”Io stanotte ridevo dentro al letto”)? L’invito a provare compassione per questa gente sembra una provocazione. Ma la compassione nasce da sé, appena ci si sofferma a considerare la terribile nudità di questi uomini e di queste donne, sospesi tra il terrore e la follia.
La scuola italiana nello specchio di quella americana
Sarebbe bello se sulla porta di ogni aula scolastica ci fosse scritto “Qui nessuno viene lasciato indietro”. Mi sembra una sintesi di quello che deve – e che può, mi piace sperare – essere una scuola perfino più efficace dell’I care di Barbiana. Purtroppo non basta una formula suggestiva per trasformare realmente la scuola. No Child Left Behind (Nessun bambino lasciato indietro) è, come è noto, il nome dell’atto del 2001 dell’amministrazione Bush jr con il compiuto dichiarato, appunto, di conciliare uguali opportunità ed elevati standard scolastici. E che invece, come mostra Andrea Mariuzzo nel recente e utilissimo Scuola e politica negli Stati Uniti 1980-2020 (Morcelliana, Brescia 2022), di bambini ne ha lasciati indietro parecchi. E, come è facile immaginare, a restare indietro sono stati quelli socialmente fragili.
L’atto del 2001 è stato l’esito di un lungo dibattito, stimolato in modo decisivo dal rapporto del Congresso A Nation at Risk, che nel 1983 evidenziava la mediocrità del sistema scolastico statunitense e in particolare il calo costante delle competenze di base degli studenti. Nell’analisi conservatrice un simile disastro era la conseguenza della concezione progressista, deweyana della scuola, che aveva favorito le competenze sociali a discapito di quelle disciplinari. Per rimediare occorreva imporre alle scuole un nucleo di competenze comuni, accertate periodicamente con dei test, e legare lo stipendio dei docenti ai risultati dei loro studenti. Ed è questa la logica sottostante all’atto del 2001.

Nessun commento :
Posta un commento