Victory
Qualche mese fa quelli di una famosa agenda mi hanno chiesto di scrivere un articolo su Foggia – la città in cui sono nato e da cui sono andato via da qualche anno – per la loro rivista. Volevano una sorta di guida, ma viva: ed appassionata. Restammo d’accordo che ci saremmo risentiti, ma come spesso accade non ci siamo risentiti. Ed è un peccato, perché mi sarebbe piaciuto scriverlo, quell’articolo. Soprattutto in questi giorni prenatalizi. Mi sarebbe piaciuto, davvero, parlare del meraviglioso albero, pieni di luci, messo davanti alla villa comunale, per comunicare la gioia del Natale e fare comunità. Avrei detto della pista di pattinaggio, una bella novità di quest’anno, che lascia perplesso qualcuno: non è che con l’insolito caldo di questo dicembre il ghiaccio finirà per sciogliersi? Avrei detto del nuovo meraviglioso mega-centro commerciale, che ha avuto un leggero inciampo – autorizzazioni che mancano, cose così: robetta burocratica – ma che riaprirà senza alcun dubbio, e porterà lavoro a centinaia di foggiani, e tanti nuovi negozi colorati a rendere più piacevoli le vite dei foggiani. Avrei detto dell’isola pedonale piena di gente, dello struscio serale, trepido e appassionato, di una comunità che si riversa in strada per appropriarsi della città. Avrei detto. Provate a dirlo sotto Natale, che Foggia è una città brutta, anzi la più brutta città d’Italia, come disse quello scrittore famoso. E provate a parlare di statistiche, di qualità della vita: eccetera.
Questo avrei scritto.
Poi, avrei parlato di Victory Uwangue. Ha ventitré anni, Victory. Dovrei dire aveva, perché Victory è morta, ma dico che li ha perché Victory è qui, accanto a me, mentre scrivo. Victory è nigeriana, e lo si capirebbe dal nome, se non lo sapessimo. Quasi tutti i nigeriani che ho conosciuto avevano questi nomi: Victory, Destiny, Goodluck. Nomi di gente che vuole crederci. Tutti i nigeriani che ho conosciuto avevano storie terribili da raccontare. La storia di Victory finisce a Foggia, anzi a Borgo Mezzanone. Ufficialmente questo borgo, creato dal fascismo per attuare la sua politica dei borghi rurali, fa parte del territorio di Manfredonia, anche se dista solo quindici chilometri da Foggia. Qui Victory vive in un ghetto, in uno dei ghetti nei quali vivono – languono, lottano, soffrono – i lavoratori-schiavi che vengono a lavorare nei campi del Foggiano.
Qui Victory sabato scorso è stata uccisa. Il suo cadavere, nudo, è stato dato alle fiamme, ma molto più probabilmente è stata bruciata viva. La foto del suo corpo nudo e semi-carbonizzato gira in rete. L’ho trovata in un blog nigeriano, ma si trova facilmente anche sui siti italiani. Nel blog nigeriano trovo tra i commenti: “They must investigate that matter. That’s if the lady is not a prostitute”. I commenti dei foggiani non sono pervenuti. I siti di informazione locale hanno dato la notizia, che però non interessa granché. Sui social è silenzio. Gli amici, per lo più gente di sinistra, discutono animatamente del nuovo governo Gentiloni e soprattutto del nuovo ministro dell’istruzione che mente sul suo titolo di studio. Sempre al ghetto di Borgo Mezzanone, e sempre la scorsa settimana, è morto bruciato un altro ragazzo di vent’anni, Ivan Miecoganuchev. La stufa ha dato fuoco alla sua capanna fatta di legno e cartone. Sono cose che succedono. Si sa, del resto, che questi stranieri fanno cose strane e terribilmente pericolose. Come quella romena – Claudia Ioana Pop, si chiamava – che quasi dieci anni fa, nel 2007, morì nel tentativo di lavarsi in una vasca per l’irrigazione, quelle cose simili a piscine che si trasformano in trappole mortali per le pareti lisce e ripide. Aveva ventisette anni e un figlio di quattro. Ricordo il suo nome perché avevo provato ad immaginarmela viva, proprio come sto facendo ora con Victory, il cui nome ricorderò tra dieci anni, e con Ivan.
Claudia Ioana, Victory, Ivan. Tre nomi per decine di vittime senza nome, donne uccise e abbandonate ai bordi della strada, lavoratori investiti mentre cercavano di raggiungere i campi in bicicletta, uomini e donne morti sul lavoro, ragazzi morti nell’incendio delle loro capanne. Abbiamo perso, Victory. Hai perso tu, ha perso chi ti ha ucciso, ha perso chi guarda dall’altra parte. Ho perso io, che scrivo di te, e che non ho saputo fare nulla di meglio che andarmene.
Articolo pubblicato su Gli Stati Generali il 15 dicembre 2016.
Victory
Breve storia della Cucina di Stato
La cosa a Comistocle ed al re ed a tutta la corte pareva un gran bell’atto di finaltropia. Un gesto generoso che i posteri avrebbero ricordato con gratitudine. Ma accadde una cosa non prevista. Per quanto gratuite, le mense reali venivano disertate. Ai sudditi non piaceva il cibo di Comistocle, benché fosse infinitamente migliore di quello delle loro povere mense. Preferivano nutrirsi di castagne e pane nero. Presto fu necessario un nuovo bando per ribadire che mangiare alle mense pubbliche era un preciso dovere dei sudditi. Nemmeno questo bastò. Le mense si riempirono solo quando il re si decise a ricorrere all’esercito. Famiglie intere venivano prelevate e portate di forza alle mense. Le quali avevano, ormai, le grate alle finestre, e le porte erano sbarrate. Fino a quando era tempo di mangiare, nessuno poteva uscire.
Anche così, i sudditi continuarono a protestare. Molti si rifiutavano di mangiare, molti altri vomitavano subito dopo aver mangiato. Particolarmente penosa era la situazione dei cuochi reali che, dopo aver studiato per anni la cucina più raffinata, si sentivano ora terribilmente umiliati. I cibi preparati con tanta passione, tanta competenza, tanto studio, erano rifiutati come se fossero stati velenosi. Perché i sudditi li assaggiassero, occorreva ricorrere alla minaccia.
Una situazione così penosa si protrasse per secoli e secoli. Stranamente, i sudditi non si adeguarono mai alla dieta di Comistocle. Continuarono a sognare le loro castagne col pane nero, assaggiando qualcosa nella mensa reale solo sotto minaccia, e il più delle volte risputandolo via. I cuochi cominciarono presto a far porzioni più piccole, per disturbare il meno possibile, e fingevano di non vedere quando qualche suddito, invece di ingoiare, buttava in qualche sacca il cibo così amorevolmente offerto. Gli uni e gli altri erano scontenti, e le mense furono per secoli tra i posti più infelici del regno. Eppure i re, uno dopo l’altro, continuarono a considerare la mensa reale indispensabile, irrinunciabile, meritoria. Il ragionamento di Comistocle era solido, capace di resistere ad ogni smentita dell’esperienza.
Fu verso la nona dinastia che accadde qualcosa. Venne fuori un cuoco popolare, un tipo strano che cucinava castagne col pane, ma in modo più raffinato, e si mise a contestare apertamente la mensa reale. Scrisse un libro intitolato Lettera a un Cuoco di Stato in cui sosteneva che non è affatto vero che la dieta comistoclea è migliore, che anche la dieta dei sudditi, caparbiamente mantenuta nei secoli nonostante l’opposizione dei governanti, aveva le sue virtù, e che i sudditi si sarebbero sentiti estranei, quasi prigionieri nelle mense di Stato – che continuavano ad avere le grate alle finestre – se alla dieta comistoclea non fosse stata aggiunta almeno qualche castagna e qualche fetta di pane nero. Altre voci si aggiunsero alle sue. Un tale si spinse fino ad affermare che meglio sarebbe stato chiudere senz’altro le mense statali, visto che nessuno vi mangiava nulla. La reazione comune fu di sdegno. Nessuno poteva considerare seriamente la proposta di cancellare una istituzione così benefica.
Ma il disagio dei sudditi, dopo secoli di cucina di Stato, era oggettivo: e crescente. Che fare? Ci si accordò tacitamente di diminuire ancora le porzioni. Oggi, dodicesima dinastia, la mensa di Stato continua ad essere una istituzione centrale nella politica dei successori di Pekkar, ed il successori di Comistocle continuano a sostenere la solidità delle ragioni del loro illustre antenato. Ma i sudditi non mangiano, e se non fosse per quel po’ di pane e castagne che riescono a buttare giù di nascosto appena usciti dalla mensa, si direbbe che siano a rischio di morire di fame. Io che scrivo queste righe, alla periferia del Regno, mi chiedo come mai ciò accada. Sommessamente, avanzo una mia ipotesi, e la affido a questa pagina nella speranza che, quando la leggerete, sarà al di là del confine. Ecco, sospetto che non si tratti in realtà di dieta, che la salute dei sudditi c’entri poco. Sospetto che da secoli la gente venga chiusa a mangiare la dieta comistoclea in mense con le sbarre alla finestra perché è così che si impara cos’è il potere.
Ora che ve l’ho detto, è bene che vada. In fretta.
Valete.
Breve storia della Cucina di Stato
La cosa a Comistocle ed al re ed a tutta la corte pareva un gran bell'atto di finaltropia. Un gesto generoso che i posteri avrebbero ricordato con gratitudine. Ma accadde una cosa non prevista. Per quanto gratuite, le mense reali venivano disertate. Ai sudditi non piaceva il cibo di Comistocle, benché fosse infinitamente migliore di quello delle loro povere mense. Preferivano nutrirsi di castagne e pane nero. Presto fu necessario un nuovo bando per ribadire che mangiare alle mense pubbliche era un preciso dovere dei sudditi. Nemmeno questo bastò. Le mense si riempirono solo quando il re si decise a ricorrere all'esercito. Famiglie intere venivano prelevate e portate di forza alle mense. Le quali avevano, ormai, le grate alle finestre, e le porte erano sbarrate. Fino a quando era tempo di mangiare, nessuno poteva uscire.
Anche così, i sudditi continuarono a protestare. Molti si rifiutavano di mangiare, molti altri vomitavano subito dopo aver mangiato. Particolarmente penosa era la situazione dei cuochi reali che, dopo aver studiato per anni la cucina più raffinata, si sentivano ora terribilmente umiliati. I cibi preparati con tanta passione, tanta competenza, tanto studio, erano rifiutati come se fossero stati velenosi. Perché i sudditi li assaggiassero, occorreva ricorrere alla minaccia.
Una situazione così penosa si protrasse per secoli e secoli. Stranamente, i sudditi non si adeguarono mai alla dieta di Comistocle. Continuarono a sognare le loro castagne col pane nero, assaggiando qualcosa nella mensa reale solo sotto minaccia, e il più delle volte risputandolo via. I cuochi cominciarono presto a far porzioni più piccole, per disturbare il meno possibile, e fingevano di non vedere quando qualche suddito, invece di ingoiare, buttava in qualche sacca il cibo così amorevolmente offerto. Gli uni e gli altri erano scontenti, e le mense furono per secoli tra i posti più infelici del regno. Eppure i re, uno dopo l'altro, continuarono a considerare la mensa reale indispensabile, irrinunciabile, meritoria. Il ragionamento di Comistocle era solido, capace di resistere ad ogni smentita dell'esperienza.
Fu verso la nona dinastia che accadde qualcosa. Venne fuori un cuoco popolare, un tipo strano che cucinava castagne col pane, ma in modo più raffinato, e si mise a contestare apertamente la mensa reale. Scrisse un libro intitolato Lettera a un Cuoco di Stato in cui sosteneva che non è affatto vero che la dieta comistoclea è migliore, che anche la dieta dei sudditi, caparbiamente mantenuta nei secoli nonostante l'opposizione dei governanti, aveva le sue virtù, e che i sudditi si sarebbero sentiti estranei, quasi prigionieri nelle mense di Stato - che continuavano ad avere le grate alle finestre - se alla dieta comistoclea non fosse stata aggiunta almeno qualche castagna e qualche fetta di pane nero. Altre voci si aggiunsero alle sue. Un tale si spinse fino ad affermare che meglio sarebbe stato chiudere senz'altro le mense statali, visto che nessuno vi mangiava nulla. La reazione comune fu di sdegno. Nessuno poteva considerare seriamente la proposta di cancellare una istituzione così benefica.
Ma il disagio dei sudditi, dopo secoli di cucina di Stato, era oggettivo: e crescente. Che fare? Ci si accordò tacitamente di diminuire ancora le porzioni. Oggi, dodicesima dinastia, la mensa di Stato continua ad essere una istituzione centrale nella politica dei successori di Pekkar, ed il successori di Comistocle continuano a sostenere la solidità delle ragioni del loro illustre antenato. Ma i sudditi non mangiano, e se non fosse per quel po' di pane e castagne che riescono a buttare giù di nascosto appena usciti dalla mensa, si direbbe che siano a rischio di morire di fame. Io che scrivo queste righe, alla periferia del Regno, mi chiedo come mai ciò accada. Sommessamente, avanzo una mia ipotesi, e la affido a questa pagina nella speranza che, quando la leggerete, sarà al di là del confine. Ecco, sospetto che non si tratti in realtà di dieta, che la salute dei sudditi c'entri poco. Sospetto che da secoli la gente venga chiusa a mangiare la dieta comistoclea in mense con le sbarre alla finestra perché è così che si impara cos'è il potere.
Ora che ve l'ho detto, è bene che vada. In fretta.
Valete.
La scuola capovolta
Il mio articolo sui poteri dei presidi (http://www.glistatigenerali.com/scuola/66332/) contiene un cenno critico alla flipped classroom che non è piaciuto ai sostenitori della metodologia: sono stato perfino espulso dal gruppo Facebook Docenti Virtuali. Cosa che, se non mi toglierà il sonno, un po’ mi sorprende, sia perché mi figuro dei docenti come persone aperte al confronto, sia perché la mia critica non riguarda la metodologia in sé, ma la sua deriva.
Per flipped classroom si intende una metodologia didattica che capovolge, letteralmente, il modo tradizionale di fare scuola. Nella scuola tradizionale al mattino il docente insegna, impiegando per lo più la metodologia della lezione frontale – che ha limiti che ormai sono evidenti a tutti, o quasi – ed al pomeriggio lo studente fa il lavoro a casa: i compiti, ossia lo svolgimento di esercizi o lo studio del libro di testo. L’assegnazione di compiti a casa è molto discussa soprattutto nella scuola primaria. Come osserva Maurizio Parodi, pedagogista che ha avviato una campagna per l’abolizione dei compiti, il bambino si ritrova da solo proprio nel momento decisivo, quello nel quale deve consolidare ed applicare – cioè rendere concrete – le conoscenze acquisite. Per questo per molti bambini il momento dei compiti si risolve in una esperienza frustrante: e l’associazione dello studio con sensazioni spiacevoli può avere conseguenze non lievi sulla futura esperienza scolastica. A dire il vero il bambino non è del tutto solo: c’è sempre la mamma o qualche altro familiare ad aiutarlo. E qui c’è un’altra perplessità. A far la differenza, alla fine, è il tipo di assistenza che il bambino può avere a casa. Un bambino con una madre laureata avrà molte più possibilità di successo scolastico di un bambino proveniente da una famiglia non in grado di seguirlo adeguatamente nei compiti. E che dire, poi, di un professionista, l’insegnante, che chiede ai genitori di completare il lavoro da lui iniziato?
Con la classe capovolta lo studente non ha più compiti a casa: quello che prima faceva a casa lo fa ora a scuola. E cosa fa a casa? Segue le lezioni. Ed è qui che si appuntava la mia critica. Perché le lezioni saranno seguite, naturalmente, davanti al un computer o a uno smartphone, e consisteranno in video nei quali il docente illustra l’argomento di studio o in altri video didattici trovati in rete. Occorre precisare che il ricorso a videolezioni non è indispensabile né caratterizza la metodologia, perché a casa lo studente può anche studiare il manuale, ma di fatto la proposta di materiali video o comunque multimediali caratterizza fortemente la metodologia. Cosa c’è che non va? La mia obiezione non riguarda la perdita di contatto umano, lo smarrimento della relazione interpersonale, poiché c’è il momento successivo in classe, nel quale si spera che si recuperi in termini di relazione quello che s’è perso al pomeriggio. A lasciarmi perplesso è la riduzione, forse non inevitabile ma effettiva, del discorso culturale, affinché rientri in un video. Tutto viene semplificato, ridotto, schematizzato. Guardando i video didattici che i docenti capovolti si scambiano, ho l’impressione che si tratti di materiale che suppone in chi lo guarderà una capacità di attenzione molto labile, per non dire peggio.
Nel gruppo Facebook La Classe Capovolta, il più importante gruppo di incontro dei docenti che praticano la metodologia, una docente segnala il sito Ovo. ” Qui si trova materiale utile per italiano, storia, arte, musica, ecc.” Seguono ringraziamenti. Una docente scrive: “Io lo conoscevo ed è molto utile…….linguaggio semplice, associa video e relativo testo…” (sic). Ed un’altra: “Grazie mille molto interessante i video sono semplici e molto d’impatto”. Semplicità ed impatto.
A chi ha buona memoria questo Ovo dirà qualcosa. Si tratta di un progetto che ha una decina di anni. Fu avviato nel 2007, dietro c’erano Trefinance, una società controllata dalla Fininvest di Silvio Berlusconi, e Nova Fronda di Antonio Meneghetti, ex frate fondatore dell’ontopsicologia, un personaggio con pose da santone di cui la magistratura si è occupata più volte. Il progetto fece scalpore, ai tempi, perché in quei video di pochi minuti sembrava prendere forma un progetto ben preciso: quello di riscrivere la storia ad uso e consumo delle nuove generazioni. Del resto, Marcello Dell’Utri lo aveva detto con chiarezza: “I libri di storia, ancora oggi condizionati dalla retorica della resistenza, saranno revisionati, se dovessimo vincere le elezioni. Questo è un tema del quale ci occuperemo con particolare attenzione”. Ma l’incontro tra Berlusconi e Meneghetti (scomparso nel 2013) non era solo all’insegna del revisionismo storico. Meneghetti aveva la fissa dei leader, degli esseri superiori che riescono a far prevalere la loro volontà. E l’idolatria della leadership è uno dei punti cardine dell’ideologia berlusconiana. Nel caso di Ovo, tuttavia, più che di formare una nuova generazione di leader, si trattava di contrastare quell’egemonia culturale della sinistra che tanto infastidiva Dell’Utri, e di farlo con la consapevolezza dei cambiamenti culturali e tecnologici in atto. Se la sinistra ha il controllo delle case editrici, la destra userà il web, i computer, i telefonini. E la comunicazione rapida, essenziale, efficace. Mettendo a frutto anni di esperienza televisiva e pubblicitaria.
A distanza di dieci anni, le pillole di Ovo diventano strumenti didattici all’avanguardia. Pier Cesare Rivoltella, docente alla Cattolica di Milano che è tra i principali riferimenti italiani dei docenti capovolti, riprende il concetto di microlearning, che spiega come segue: “Se io ho il mio cellulare e ascolto il podcast di una lezione universitaria sul tram, è evidente che quella lezione non potrà durare venti minuti, venticinque minuti, trenta minuti. Ma neanche dieci”. Cinque minuti di lezione, da ascoltare sul tram. Come uno spot pubblicitario: nulla più.
Resta da chiedersi perché seguire una lezione universitaria in tram. Non ho l’ideologia dello studio faticoso, che richiede disciplina e sofferenza. Sono persuaso che sia compito di chi insegna rendere l’apprendimento quanto più possibile una esperienza positiva, perfino gioiosa. Ma resta una esperienza che ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi: come tutte le cose importanti. Non si studia tra la lettura di un sms e la fermata del tram. Si studia prendendosi il tempo necessario e concentrandosi. Si studia, soprattutto, andando a fondo nelle cose. Le dosi omeopatiche di cultura generano solo una ignoranza piena di presunzione. Il rischio è quello di una scuola che, nel tentativo disperato di inseguire la società, smarrisce quello che è il suo compito: educare al pensiero rigoroso, all’approfondimento dei problemi, all’analisi attenta, alla concentrazione, che è una questione esistenziale e non solo metodologica. Intelligenza è guardare dentro. Se si resta alla superficie, si educa alla stupidità.
Articolo pubblicato su Gli Stati Generali il 3 settembre 2016.
I nuovi poteri dei presidi, la nuova impotenza dei docenti
G. è giovane, colta, brillante. Le piace insegnare, ed ai suoi studenti piace il suo modo di insegnare. E verrebbe dunque da darle ragione: questa cosa no, non dev’essere così terribile. Ma c’è un particolare della faccenda che mi impedisce di partecipare al suo ottimismo. Il suo incarico, quello che ha ottenuto grazie al suo curriculum, è triennale. Tre anni di insegnamento: e poi? Poi dipende da te, certo. Può essere che quella scuola non ti piaccia, che tu voglia cambiare città o semplicemente scuola. Ma dipende soprattutto dal preside. E’ il preside che dopo tre anni decide se è il caso che tu rimanga in quella scuola o debba cercarti un altro posto per insegnare.
Non è difficile immaginare le implicazioni di questo sistema. Abbiamo una nuova classe di docenti la cui sorte dipende interamente dai presidi. Sono assunti direttamente dal preside e il preside stesso può mandarli via se non piacciono più. Che ne sarà della loro libertà, della loro indipendenza, del loro spirito critico? Le cronache scolastiche degli ultimi tempi ci hanno consegnato l’aggettivo contrastivo, associato ai docenti. L’aggettivo, guarda caso, è balzato fuori da una slide di un corso della Associazione Nazionale dei Presidi. Il contesto era: “mano libera nei confronti dei docenti contrastivi”. Uno dei nuovi poteri dei presidi garantiti dalla riforma. Chi sono i docenti contastivi? Quelli che si oppongono. Quelli che hanno un’idea di scuola diversa rispetto a quella del loro preside, o che magari hanno qualche perplessità riguardo al modo in cui vengono spesi i soldi. Certo, non manca qualche docente contrastivo per temperamento e vocazione, ma nel complesso per la scuola italiana che ci siano docenti contrastivi è più un bene che un male. Vuol dire che le procedure vengono sottoposte a verifica, che c’è dibattito, confronto, dialettica. Vuol dire che c’è democrazia.
Ora, nei confronti dei docenti contrastivi la mano non è libera: è liberissima. Il docente contrastivo poteva trovarsi emarginato, più o meno mobbizzato, ma nessuno poteva davvero impedirgli di parlare e di mettere a verbale le sue dichiarazioni. Aveva tutte le garanzie della legge. Adesso quelle garanzie restano, formalmente. Ma mentre sempre più si riduce l’ambito di competenza del Collegio dei docenti, ossia l’organo che gestisce democraticamente la scuola (un solo esempio: l’animatore digitale e i membri del team per l’innovazione sono stati scelti direttamente dai presidi), la sorte professionale dei nuovi docenti è legata a doppio filo alla volontà dei presidi. Ogni contrastività, ogni opposizione alla politica del preside costerà non solo l’emarginazione e la mobbizzazione, più o meno pesante. Costerà la cattedra su quella scuola. I presidi potranno contare su Collegi dei docenti sempre più perfettamente allineati, almeno su quelle poche cose di sua competenza (per il resto, farà da solo). Se allarghiamo lo sguardo, questo dirigente statale le cui dimensioni sembrano essere cresciute a dismisura, torna a farsi piccino: perché non è, a sua volta, che una pedina, uno strumento nelle mani di un potere più grande. Dare potere ai presidi è un modo, per il Ministero, per controllare la scuola. Se controlli un preside che controlla la scuola, hai controllato la scuola. I poteri che il governo dà ai presidi sono poteri che dà a sé stesso. Nella politica di allineamento, che si sta chiaramente delineando, il preside non è che un esecutore, cui si chiede di adeguarsi alle politiche dall’alto e rendersi garante della loro applicazione.
La professione dell’insegnante sta cambiando in modo talmente rapido da lasciare sconvolti. Tra i nuovi poteri dati ai presidi c’è anche questo: di decidere in quale direzione deve andare la professione docente. Dimenticatevi la libertà di insegnamento. Ora il modo di insegnare sarà deciso da questo nuovo, singolare mercato. Saranno i presidi a decidere quali competenze sono importanti. C’è il preside che chiede che i candidati si presentino con un video a figura intera; e si commenta con malizia: vorrà vedere se il candidato, o più probabilmente la candidata, ha belle gambe. Sfugge la cosa più grave: quel preside ha deciso che saper stare davanti ad un video è una competenza-chiave, e in base a quella sua convinzione – discutibilissima – deciderà chi assumere e chi no. E’ una dei profili di maggior successo, e bisogna ammettere che qui il ministero c’entra poco. Molto si deve alla cosiddetta flipped classroom, che si è diffusa dal basso, e che ha trasformato il modo di intendere la professione docente. Basta lezioni frontali: e questo va benissimo, sono decenni che lo dice tutta la pedagogia più avvertita. Ma cosa mettiamo al posto delle lezioni? Ed è qui che la metodologia, che può avere applicazioni interessantissime, spesso scade in qualcosa che rischia di essere perfino peggio della lezione frontale. Agli studenti, impegnati al pomeriggio secondo la logica capovolta, i docenti propongono video da guardare comodamente a casa. Video che sono di due tipi: o prodotti dal docente stesso, o trovati in rete. Il docente dunque diventa un produttore di video didattici o una sorta di deejay didattico, che mixa e propone video prodotti da altri. E non è detto che questo secondo caso sia peggiore, perché per quanto sappia usare gli strumenti informatici, sia telegenico ed abbia una bella voce, un docente difficilmente supererà i professionisti della divulgazione televisiva. Il docente videogenico, produttore di materiali didattici informatici, è uno dei profili vincenti. Si integra alla perfezione nel Piano Nazionale Scuola Digitale, che è come dire l’autostrada della scuola renziana. Un altro profilo di buon successo è il docente bilingue: servirà per il CLIL, ossia l’insegnamento di una disciplina in una lingua straniera; non proprio un’autostrada, ma una strada rispettabile e redditizia. La sua competenza naturalmente dovrà essere adeguatamente certificata, perché nell’epoca della selezione tramite curriculum conta solo quello che puoi certificare. La corsa alle certificazioni è già iniziata, ed apre un mercato significativo, alimentato anche dal bonus di cinquecento euro per la formazione dei docenti.
Quale spazio resterà per la sperimentazione di una scuola dal basso, diversa da quella proposta/imposta dal ministero? Che ne sarà della libertà di insegnamento? Che ne sarà dello studio intenso, profondo, rigoroso di un testo, in una scuola che va verso la divertente divulgazione audiovisiva? Che ne sarà della scuola come palestra di critica sociale? Che ne sarà della democrazia, delle scelte condivise, della collegialità? Si dirà che è da tempo che la democrazia scolastica è in crisi. E’ vero. I collegi dei docenti sono, in molte scuole, penosi happening e psicodrammi nei quali si approva qualsiasi cosa pur di andarsene a casa e farla finita. Quanto alle assemblee degli studenti, in molte scuole (la maggior parte di quelle cui ho insegnato) semplicemente non si tengono: si va a casa, se va bene i rappresentanti restano per una mezz’ora a chiacchierare tra di loro. Ma quando c’è poca democrazia, o la democrazia funziona poco, bisogna chiedersi come fare affinché ci sia e funzioni. Non togliere anche quel poco di democrazia che c’è.
Si assiste con impotenza a questo nuovo scenario. La scuola che abbiamo frequentato come studenti non c’è più. La scuola nella quale abbiamo insegnato per anni non c’è più. E questa potrebbe essere una buona notizia, perché la scuola che abbiamo frequentato come studenti aveva molti mali, tutt’altro che lievi, e questi mali sono rimasti nella scuola in cui si siamo trovati a lavorare come docenti. Ma lo scenario della nuova scuola che si sta delineando suscita preoccupazione. L’impressione è che stiamo assistendo al passaggio dall’istruzione all’intrattenimento di massa.
Articolo pubblicato su Gli Stati Generali il 31 agosto 2016.
La scuola capovolta
I nuovi poteri dei presidi, la nuova impotenza dei docenti
G. è giovane, colta, brillante. Le piace insegnare, ed ai suoi studenti piace il suo modo di insegnare. E verrebbe dunque da darle ragione: questa cosa no, non dev'essere così terribile. Ma c'è un particolare della faccenda che mi impedisce di partecipare al suo ottimismo. Il suo incarico, quello che ha ottenuto grazie al suo curriculum, è triennale. Tre anni di insegnamento: e poi? Poi dipende da te, certo. Può essere che quella scuola non ti piaccia, che tu voglia cambiare città o semplicemente scuola. Ma dipende soprattutto dal preside. E' il preside che dopo tre anni decide se è il caso che tu rimanga in quella scuola o debba cercarti un altro posto per insegnare.
Non è difficile immaginare le implicazioni di questo sistema. Abbiamo una nuova classe di docenti la cui sorte dipende interamente dai presidi. Sono assunti direttamente dal preside e il preside stesso può mandarli via se non piacciono più. Che ne sarà della loro libertà, della loro indipendenza, del loro spirito critico? Le cronache scolastiche degli ultimi tempi ci hanno consegnato l'aggettivo contrastivo, associato ai docenti. L'aggettivo, guarda caso, è balzato fuori da una slide di un corso della Associazione Nazionale dei Presidi. Il contesto era: "mano libera nei confronti dei docenti contrastivi". Uno dei nuovi poteri dei presidi garantiti dalla riforma. Chi sono i docenti contastivi? Quelli che si oppongono. Quelli che hanno un'idea di scuola diversa rispetto a quella del loro preside, o che magari hanno qualche perplessità riguardo al modo in cui vengono spesi i soldi. Certo, non manca qualche docente contrastivo per temperamento e vocazione, ma nel complesso per la scuola italiana che ci siano docenti contrastivi è più un bene che un male. Vuol dire che le procedure vengono sottoposte a verifica, che c'è dibattito, confronto, dialettica. Vuol dire che c'è democrazia.
Ora, nei confronti dei docenti contrastivi la mano non è libera: è liberissima. Il docente contrastivo poteva trovarsi emarginato, più o meno mobbizzato, ma nessuno poteva davvero impedirgli di parlare e di mettere a verbale le sue dichiarazioni. Aveva tutte le garanzie della legge. Adesso quelle garanzie restano, formalmente. Ma mentre sempre più si riduce l'ambito di competenza del Collegio dei docenti, ossia l'organo che gestisce democraticamente la scuola (un solo esempio: l'animatore digitale e i membri del team per l'innovazione sono stati scelti direttamente dai presidi), la sorte professionale dei nuovi docenti è legata a doppio filo alla volontà dei presidi. Ogni contrastività, ogni opposizione alla politica del preside costerà non solo l'emarginazione e la mobbizzazione, più o meno pesante. Costerà la cattedra su quella scuola. I presidi potranno contare su Collegi dei docenti sempre più perfettamente allineati, almeno su quelle poche cose di sua competenza (per il resto, farà da solo). Se allarghiamo lo sguardo, questo dirigente statale le cui dimensioni sembrano essere cresciute a dismisura, torna a farsi piccino: perché non è, a sua volta, che una pedina, uno strumento nelle mani di un potere più grande. Dare potere ai presidi è un modo, per il Ministero, per controllare la scuola. Se controlli un preside che controlla la scuola, hai controllato la scuola. I poteri che il governo dà ai presidi sono poteri che dà a sé stesso. Nella politica di allineamento, che si sta chiaramente delineando, il preside non è che un esecutore, cui si chiede di adeguarsi alle politiche dall'alto e rendersi garante della loro applicazione.
La professione dell'insegnante sta cambiando in modo talmente rapido da lasciare sconvolti. Tra i nuovi poteri dati ai presidi c'è anche questo: di decidere in quale direzione deve andare la professione docente. Dimenticatevi la libertà di insegnamento. Ora il modo di insegnare sarà deciso da questo nuovo, singolare mercato. Saranno i presidi a decidere quali competenze sono importanti. C'è il preside che chiede che i candidati si presentino con un video a figura intera; e si commenta con malizia: vorrà vedere se il candidato, o più probabilmente la candidata, ha belle gambe. Sfugge la cosa più grave: quel preside ha deciso che saper stare davanti ad un video è una competenza-chiave, e in base a quella sua convinzione - discutibilissima - deciderà chi assumere e chi no. E' una dei profili di maggior successo, e bisogna ammettere che qui il ministero c'entra poco. Molto si deve alla cosiddetta flipped classroom, che si è diffusa dal basso, e che ha trasformato il modo di intendere la professione docente. Basta lezioni frontali: e questo va benissimo, sono decenni che lo dice tutta la pedagogia più avvertita. Ma cosa mettiamo al posto delle lezioni? Ed è qui che la metodologia, che può avere applicazioni interessantissime, spesso scade in qualcosa che rischia di essere perfino peggio della lezione frontale. Agli studenti, impegnati al pomeriggio secondo la logica capovolta, i docenti propongono video da guardare comodamente a casa. Video che sono di due tipi: o prodotti dal docente stesso, o trovati in rete. Il docente dunque diventa un produttore di video didattici o una sorta di deejay didattico, che mixa e propone video prodotti da altri. E non è detto che questo secondo caso sia peggiore, perché per quanto sappia usare gli strumenti informatici, sia telegenico ed abbia una bella voce, un docente difficilmente supererà i professionisti della divulgazione televisiva. Il docente videogenico, produttore di materiali didattici informatici, è uno dei profili vincenti. Si integra alla perfezione nel Piano Nazionale Scuola Digitale, che è come dire l'autostrada della scuola renziana. Un altro profilo di buon successo è il docente bilingue: servirà per il CLIL, ossia l'insegnamento di una disciplina in una lingua straniera; non proprio un'autostrada, ma una strada rispettabile e redditizia. La sua competenza naturalmente dovrà essere adeguatamente certificata, perché nell'epoca della selezione tramite curriculum conta solo quello che puoi certificare. La corsa alle certificazioni è già iniziata, ed apre un mercato significativo, alimentato anche dal bonus di cinquecento euro per la formazione dei docenti.
Quale spazio resterà per la sperimentazione di una scuola dal basso, diversa da quella proposta/imposta dal ministero? Che ne sarà della libertà di insegnamento? Che ne sarà dello studio intenso, profondo, rigoroso di un testo, in una scuola che va verso la divertente divulgazione audiovisiva? Che ne sarà della scuola come palestra di critica sociale? Che ne sarà della democrazia, delle scelte condivise, della collegialità? Si dirà che è da tempo che la democrazia scolastica è in crisi. E' vero. I collegi dei docenti sono, in molte scuole, penosi happening e psicodrammi nei quali si approva qualsiasi cosa pur di andarsene a casa e farla finita. Quanto alle assemblee degli studenti, in molte scuole (la maggior parte di quelle cui ho insegnato) semplicemente non si tengono: si va a casa, se va bene i rappresentanti restano per una mezz'ora a chiacchierare tra di loro. Ma quando c'è poca democrazia, o la democrazia funziona poco, bisogna chiedersi come fare affinché ci sia e funzioni. Non togliere anche quel poco di democrazia che c'è.
Si assiste con impotenza a questo nuovo scenario. La scuola che abbiamo frequentato come studenti non c'è più. La scuola nella quale abbiamo insegnato per anni non c'è più. E questa potrebbe essere una buona notizia, perché la scuola che abbiamo frequentato come studenti aveva molti mali, tutt'altro che lievi, e questi mali sono rimasti nella scuola in cui si siamo trovati a lavorare come docenti. Ma lo scenario della nuova scuola che si sta delineando suscita preoccupazione. L'impressione è che stiamo assistendo al passaggio dall'istruzione all'intrattenimento di massa.
25 agosto, giovedì
Siedo sul balcone. Davanti ho la valle, di là dalla valle il paese. Quasi tutte le case sono spente, qualcuna ancora s’aggrappa all’ultima luce. Non un solo cane abbaia, nulla parla. Dietro le case il cielo. Due stelle verticali, una rosseggia, l’altra è fredda. Altre stelle sparse a caso. Respirano, ansimano.
Mentre la cagna che vive con noi raspava nei cespugli, prima, ho pensato a me vecchio. Alla vita che ti fa man mano più solo, più sopravvissuto. E poi uccide anche te.
Guardo le stelle con il peso di questa condanna: della solitudine, della morte. Sento la mano fredda della notte che mi attraversa da parte a parte, e so che vivere è lasciarsi abitare dal nulla.
Quando anche questa casa non sarà più, avrò dentro questo balcone sul cielo, sulle stelle, sul nulla.
25 agosto, giovedì
Le donne viennesi e il burkini
Che le ragazze anche nella più calda estate giocassero al tennis con abiti corti o peggio a braccia nude, sarebbe stato considerato scandaloso, e se una signora ben educata incrociava i piedi in società, ne erano offesi i buoni costumi, perché avrebbero potuto apparire sotto l’orlo della veste i suoi malleoli. Persino agli elementi naturali, al sole, all’acqua e all’aria, non era lecito sfiorare la pelle nuda delle donne. Esse nuotavano a fatica con pesanti costumi, coperte dal collo al tallone, e nei collegi e nei conventi le ragazze, perché dimenticassero di avere un corpo, dovevano persino fare il bagno in lunghi camici bianchi. Non è leggenda né esagerazione che morissero allora in tarda età donne del cui corpo, all’infuori del marito, dell’ostetrico e di chi ne lavava la salma, non erano mai stati veduti neppure le spalle o i ginocchi. (S. Zweig, Il mondo di ieri, Mondadori, Milano 1954)
Le donne viennesi e il burkini
Che le ragazze anche nella più calda estate giocassero al tennis con abiti corti o peggio a braccia nude, sarebbe stato considerato scandaloso, e se una signora ben educata incrociava i piedi in società, ne erano offesi i buoni costumi, perché avrebbero potuto apparire sotto l'orlo della veste i suoi malleoli. Persino agli elementi naturali, al sole, all'acqua e all'aria, non era lecito sfiorare la pelle nuda delle donne. Esse nuotavano a fatica con pesanti costumi, coperte dal collo al tallone, e nei collegi e nei conventi le ragazze, perché dimenticassero di avere un corpo, dovevano persino fare il bagno in lunghi camici bianchi. Non è leggenda né esagerazione che morissero allora in tarda età donne del cui corpo, all'infuori del marito, dell'ostetrico e di chi ne lavava la salma, non erano mai stati veduti neppure le spalle o i ginocchi. (S. Zweig, Il mondo di ieri, Mondadori, Milano 1954)
La dimostrazione dell'esistenza di Dio
Guarda questa pietra. Ad essere precisi, dovrei dire pietruzza. Sassolino, a voler essere buoni. Certo non sasso: sasso è eccessivo. Eppure il biglietto che l’accompagna la chiama senz’altro sasso. Ed a ragione. Perché questa pietruzza o sassolino non è una pietruzza qualsiasi. Leggi bene. E’ un “Sasso della grotta ove si rifugiò in Egitto la Sacra Famiglia”. Vogliamo negargli lo status di sasso? Giammai: tanto più che questo mirabile reperto, che si trova oggi in una teca a palazzo Pfanner, a Lucca, dimostra l’esistenza di Dio.
Chiudi gli occhi e seguimi. Siamo in Egitto, siamo in una grotta. Ecco qui Giuseppe e Maria. Sì, Giuseppe ha il mantello e il bastone e Maria è bionda con gli occhi azzurri ed il manto immacolato. E’ giovane, mentre Giuseppe mostra il triplo dei suoi anni. Poi c’è il bambino, anzi il Bambino, anche lui, anzi Lui, biondo con gli occhi azzurri e paffutello anzi che no. Dunque Giuseppe e Maria sono in questa grotta con Gesù. Che fanno? Direi che Maria sta cucinando, se la cosa non sembrasse blasfema. Cucinava, Maria? Certo la sacra famiglia (la Sacra Famiglia) mangiava, ed essendo poveri certo non avevano la cuoca. Ma non si può escludere che scendesse qualche angelo a sbrigare la faccenda, o che le pietanze comparissero miracolosamente sulla tavola. Dunque Maria non cucinava, pregava ardentemente Dio o leggeva qualche libro rilegato in marocchino, magari le bozze in anticipo del Vangelo di Luca. Giuseppe invece lavora: a lui lavorare era concesso, è perfino il protettore dei falegnami. Era lì, allora, a piallare una tavola di legno. Finché la pace della grotta viene turbata da un urlo. E’ Giuseppe. All’urlo non segue una bestemmia, perché Giuseppe è San Giuseppe e non bestemmia. La Madonna lo guarda con sguardo interrogativo, epperò pieno di amore – di un amore, sia chiaro, privo di qualsiasi concupiscenza, sia perché Maria è vergine (è Vergine) e non pensa a queste cose, sia perché Giuseppe va per la cinquantina e non è quello che si dice un bell’uomo. Si guarda i poveri sandali, Giuseppe, e ne estrae una pietruzza. Poi la mostra a Maria, sorridendo. Maria risponde al sorriso, pacificata. Giuseppe riprende il lavoro, non prima però di aver preso un biglietto, di avervi scritto “Sasso della grotta ove si rifugiò la Sacra Famiglia” e di averlo riposto in un canto della grotta, pensando già a quando, secoli dopo, il sassolino, promosso a sasso, sarebbe diventato una preziosa reliquia, dimostrazione infallibile dell’esistenza di Dio.
E veniamo alla dimostrazione.
Alcuni malnati sostengono che Dio non è. Se Dio non è, il mondo non è stato creato, ma ha cause meramente fisiche. Se Dio non è, le specie animali non sono state create da Dio; la vita è nata grazie a processi chimico-fisici, e le specie si sono evolute secondo le ben note leggi della selezione naturale. La vita si è sviluppata in forme sempre più intelligenti, fino a giungere all’essere umano, l’essere più evoluto ed intelligente di tutti, il risultato di milioni di anni di selezione.
Ora, se così fosse, se cioè davvero la specie umana fosse il risultato di una evoluzione di milioni di anni, non si spiegherebbe la spaventosa idiozia di chi crede che quella pietruzza possa provenire dalla grotta egiziana della Sacra Famiglia. Se una pietruzza del genere esiste – accompagnata da quel biglietto, voglio dire – è perché l’essere umano è radicalmente, disperatamente, irrimediabilmente idiota. Sia chiaro: non è, quella pietruzza, l’unica dimostrazione. Basterebbe prendere un pezzo qualsiasi della storia sacra per dimostrare lo stesso assunto. Il fatto che un coacervo di idiozie ed assurdità come il cristianesimo abbia ormai duemila anni dimostra abbondantemente l’idiozia umana. Se non vi basta, aprite a caso un libro di storia. O un giornale.
Dunque: l’essere umano è idiota. Scemo, se preferite. Coglione, se gradite questa sfumatura. Questa coglionaggine è incompatibile con la selezione naturale. Non è credibile che la natura in milione di anni abbia selezionato una specie di coglioni. Logica vuole che le cose siano andate diversamente. E precisamente, come racconta la Bibbia. Un essere umano così idiota non può che essere l’opera di un Dio quale è quello (Quello) che compare nella Bibbia. Un Dio bizzoso, rissoso, umorale, illogico, violento. Un degno padre (Padre) di un tale figlio.
Dio è, perché un essere umano così idiota non può che venire da lì (da Lì). E quella pietruzza, seu sasso, ce lo dimostra in modo inconfutabile.
La dimostrazione dell'esistenza di Dio
Dunque: l'essere umano è idiota. Scemo, se preferite. Coglione, se gradite questa sfumatura. Questa coglionaggine è incompatibile con la selezione naturale. Non è credibile che la natura in milione di anni abbia selezionato una specie di coglioni. Logica vuole che le cose siano andate diversamente. E precisamente, come racconta la Bibbia. Un essere umano così idiota non può che essere l'opera di un Dio quale è quello (Quello) che compare nella Bibbia. Un Dio bizzoso, rissoso, umorale, illogico, violento. Un degno padre (Padre) di un tale figlio.
Raca!
Ora, quale appartenente al mondo laicista, o più banalmente come persona che non appartiene alla setta cristiana, dovrei essere anch’io teologicamente ignorante, ma non lo sono fino al punto di ignorare quel passo del Vangelo secondo Matteo in cui Gesù, o chi per lui, dice:
Voi avete udito che fu detto agli antichi: “Non uccidere: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale”; ma io vi dico: “chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale; e chi avrà detto a suo fratello: ‘Raca’ sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli avrà detto: ‘Pazzo!’ sarà condannato alla geenna del fuoco.”
Raca. E che vuol dire raca? Lo lascio dire a San Girolamo, il traduttore della Vulgata:
Hoc verbum proprie Hebraeorum est: RACA enim dicitur κενὸς, id est, inanis aut vacuus: quem nos possumus vulgara iniuria, absque cerebro, nuncupare.
In altri termini, raca vuol dire cretino. Ci sarebbe, a dire il vero, da notare che cretino propriamente deriva da cristiano, ma dubito che il monsignore volesse dare a Renzi del cristiano. Cretino sta proprio per inanis e vacuus. Ora, ci sarebbe da prendere questo monsignore e portarlo al tribunale, giusto per mettere in pratica una volta tanto in Vangelo, ma i giudici hanno già il loro bel da fare: e una risata è più che sufficiente per questo pastore di pecore cristiane e “studioso” che non ha troppa memoria del Vangelo.
Allahu Akbar
Allahu Akbar. Nel mio studio su Gandhi ho cercato di mostrare l’importanza che nel suo pensiero ha l’idea di Dio come Daridranarayana: Dio come povero. E’ il rovesciamento di quella idea di Dio che, in campo hinduista, si trova nella Bhagavad-Gita, libro che pure Bapu considerava fondamentale per la sua formazione spirituale, etica e politica. Dio è povero, è debole, è umile. Dio è negli intoccabili, che non a caso Bapu chiamava harijan, figli di Dio. Dio non è grande, Dio è piccolo. Dio è nelle cose piccole, e credere in Dio significa prendersi cura delle cose piccole. L’idea non è una creazione di Gandhi: l’ho trovata in Vivekananda, un pensatore che andrebbe riscoperto, ma forse si potrebbe risalire più indietro. Dio è grande: su questa convinzione si regge tutta l’arte occidentale; senza questa convinzione non avremmo il duomo di Monreale, Santa Maria Novella, San Pietro: eccetera. Dio è grande, e dunque bisogna onorarlo con la grande architettura, con la grande arte, con la grande musica. Ma Dio è grande vuol dire anche glorificare la potenza, la violenza, l’imposizione. Il Dio grande è sempre, anche, il Signore degli eserciti della Bibbia, il Dio assassino che guida i massacri e le crociate. Bisognerebbe cominciare a pensare che Dio è piccolo e sta nei piccoli. E che le pratiche religiose sono pratiche di attenzione e di cura verso ciò che è piccolo, debole, indifeso.
Raca!
Ora, quale appartenente al mondo laicista, o più banalmente come persona che non appartiene alla setta cristiana, dovrei essere anch'io teologicamente ignorante, ma non lo sono fino al punto di ignorare quel passo del Vangelo secondo Matteo in cui Gesù, o chi per lui, dice:
Voi avete udito che fu detto agli antichi: "Non uccidere: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale"; ma io vi dico: "chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale; e chi avrà detto a suo fratello: 'Raca' sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli avrà detto: 'Pazzo!' sarà condannato alla geenna del fuoco."Raca. E che vuol dire raca? Lo lascio dire a San Girolamo, il traduttore della Vulgata:
Hoc verbum proprie Hebraeorum est: RACA enim dicitur κενὸς, id est, inanis aut vacuus: quem nos possumus vulgara iniuria, absque cerebro, nuncupare.In altri termini, raca vuol dire cretino. Ci sarebbe, a dire il vero, da notare che cretino propriamente deriva da cristiano, ma dubito che il monsignore volesse dare a Renzi del cristiano. Cretino sta proprio per inanis e vacuus. Ora, ci sarebbe da prendere questo monsignore e portarlo al tribunale, giusto per mettere in pratica una volta tanto in Vangelo, ma i giudici hanno già il loro bel da fare: e una risata è più che sufficiente per questo pastore di pecore cristiane e "studioso" che non ha troppa memoria del Vangelo.


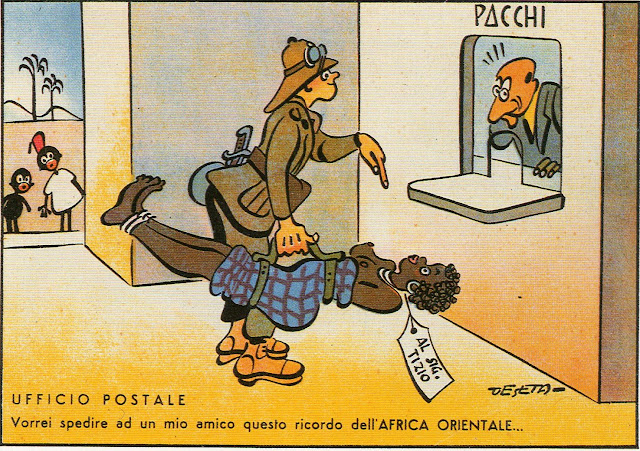

Nessun commento :
Posta un commento